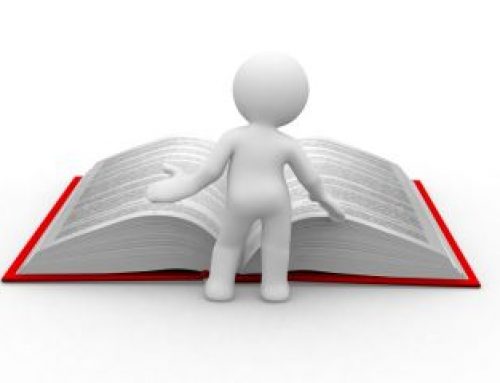Ricopio questo articolo dal vecchio sito BG2 a memoria. Mi è stato donato dal caro amico Filippo anni fa per farmi riflettere. Ed è bello e giusto rileggerlo periodicamente.
Una pagina su cui riflettere a lungo e ciclicamente nel tempo malato in cui spesso ci si vergogna dei propri genitori. Una pagina da rileggere spesso e da centellinare, non certo per piaggeria immotivata nei confronti di Nicola Gratteri, che ne riprende spesso i contenuti in occasione delle tante premiazioni che riceve per il suo impegno di lotta (vera) alla ndrangheta, ma per capire come e quanto l’esempio buono dei genitori incida sul costume dei figli, come e quanto la Calabria abbia da imparare , ma anche tanto da insegnare in termini di civiltà del lavoro, di giustizia sociale , di coraggio civile e di dignità. E solo chi vive di superbia, di intrallazzo, di vanità disprezza l’ umile espressione che dà il titolo a questa pagina e che è fiorita innumerevoli volte sulle labbra dei nostri vecchi. (Bruno Demasi)
“Ogni volta che mi guardo allo specchio scopro di assomigliare sempre di più ai miei genitori. Le radici sono tutto. Mia madre e mio padre mi hanno fatto capire l’importanza del sacrificio, dell’onestà e dell’amore verso il prossimo. Io sono il terzo di cinque figli. Da mio padre ho preso la rettitudine, ma anche la sobrietà dei sentimenti. Ricordo che i miei erano misurati anche quando succedeva qualcosa di cui gioire. Dicevano: «Pari bruttu», sembra brutto gioire eccessivamente, faremmo un torto a chi sta peggio di noi e non ha motivo di rallegrarsi.
Mio padre Francesco, negli anni Cinquanta, aveva comprato un piccolo camion con cui trasportava cereali e ghiaia nei paesi della Locride, in Calabria, per conto di agricoltori e imprenditori della zona. Poi rilevò un negozio di generi alimentari da suo zio e cominciò a vendere pasta, ma anche vino che produceva in proprio con l’uva acquistata a Cirò. Gli ultimi quindici anni della sua vita li ha vissuti su una sedia a rotelle, in seguito a un ictus che lo privò anche della parola.
Era taciturno, parlava con gli occhi. Da piccolo io ero vispo, non stavo mai fermo. E bastava uno sguardo di mio padre per mettermi in riga. Spesso le prendevo. E mi ricordo ancora oggi tutte le ragioni per le quali mio padre mi dette qualche ceffone. Ma la cosa che ricordo di più è la sua generosità. Aveva un appezzamento di terreno dove coltivava di tutto. E ogni anno ammazzava due maiali, uno per la famiglia e un altro per i poveri. Era una festa, c’era il senso della comunità. Quando poi acquistò il negozio di generi alimentari, diventò ancora più triste. Odiava stare fermo dietro un bancone. A Gerace quasi tutti acquistavano con la “libretta”, a credito. Pagavano una volta all’anno con i soldi ricavati dalle vendite delle bestie alla fiera della Madonna del Carmine, nella seconda metà di
«Poveretti, devono mangiare pure loro» diceva per giustificare i continui ritardi nei pagamenti. Mia madre era simile a mio padre, anche lei molto parca nella manifestazione dei sentimenti. Ma sapeva essere dolce, affettuosa. Era anche molto forte. Pesava le persone con lo sguardo e i suoi giudizi erano cassazione. Non si sbagliava mai sulle persone. Come mio padre, aveva studiato poco. Mi pare che avesse fatto la terza elementare.
Ai suoi tempi, le ragazze, più che a scuola, andavano dalla sarta a imparare a cucire. Anch’io ho fatto quella trafila. E di questo sono grato ai miei genitori. Da piccolo ogni estate andavo a imparare un mestiere. Ho fatto il calzolaio con mastro Felice, ma anche il meccanico, il panettiere e il manovale.
Ho imparato a stare e a vivere tra la gente, a capire l’importanza del lavoro e del sacrificio.
Ho frequentato le elementari a Gerace e le medie e il liceo scientifico a Locri. A Gerace dove ho avuto insegnanti molto sensibili mi sono trovato subito a mio agio. Eravamo tutti figli di gente modesta. A Locri invece ho studiato con figli di professionisti o comunque con gente molto diversa economicamente dalla mia famiglia e dalle mie abitudini che erano molto frugali.
Ricordo il mio compagno di banco. Era un ragazzo taciturno. Gli avevano ammazzato il padre in un agguato di mafia. Quando gli facevo qualche domanda si infastidiva. Molti anni dopo fece la fine del padre. Era entrato nello stesso giro. In classe con me c’era anche la figlia di un noto boss della ‘ndrangheta, mentre un compagno di giochi me lo sono trovato di fronte in un’aula di tribunale. Abitava vicino a mia zia Savina, la sorella di mio padre, in contrada Gabella, a Locri. Giocavamo a nascondino. Era un ragazzo molto generoso, anche lui figlio di contadini. Da grande cominciò a frequentare il clan Cataldo. Durante una perquisizione la polizia gli trovò in casa un arsenale. Come pubblico ministero chiesi e ottenni la sua condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione di armi e munizioni da guerra. Ci siamo guardati negli occhi e, senza parlare, ci siamo detti tante cose. Poi le nostre strade si sono nuovamente divise.
Oltre a essere vispo, io studiavo poco. Avevo una memoria di ferro e riuscivo a ricordare tutto ciò che gli insegnanti dicevano in classe. Poi, arrivato a casa, prendevo la bicicletta e pedalavo per ore. Ogni tanto giocavo anche a calcio, ma non ero bravo. Poi comprai un ciclomotore e cominciai a provare l’ebbrezza della velocità. Correvo come un pazzo.
Lavoravo, mi davo da fare. Nel 1974, dopo aver aiutato i miei nella pigiatura dell’uva, con il Caballero di un amico andai a fare una passeggiata a Locri. Era settembre, faceva ancora caldo. Feci incautamente una inversione a U e venni travolto da una Citroën. L’impatto fu tremendo. Sono stato in coma per dodici giorni, e tre mesi senza camminare.
Mio padre legò il motorino a una trave del garage e fui costretto a camminare a piedi.
L’anno dopo accadde qualcosa che cambiò la mia vita.
Mio zio Antonino, il fratello di mia madre, si ammalò seriamente. Gli diagnosticarono un tumore al pancreas e si spense in poco tempo. Era un avvocato civilista molto apprezzato. Conosceva i classici e recitava a memoria le tragedie di Shakespeare.
Negli ultimi mesi della sua vita dormivamo nella casa di nonna Sina, la sera mi fermavo davanti al suo letto e rimanevo incantato dai suoi ragionamenti. Capii che dovevo cambiare vita. E cominciai a studiare. Dopo la maturità scientifica, mi iscrissi alla facoltà di Legge dell’università di Catania. E lo feci per evitare Messina, dove si erano iscritti molti amici e conoscenti della Locride. Ho cominciato a studiare come un pazzo. Mi facevo la barba una volta alla settimana, di sera non uscivo quasi mai e leggevo di tutto.
Ero ossessionato dal trascorrere del tempo. Mangiavo yogurt, pomodori e panini. Dormivo pochissimo, mi addormentavo quasi sempre con la luce accesa. Una notte, durante un temporale, un cortocircuito provocò l’incendio della termocoperta, delle lenzuola e di parte del materasso. Anche in quella circostanza, la sorte è stata dalla mia parte. Ma dormivo poco anche perché mi sentivo in colpa con i miei.
Non volevo gravare più del dovuto sulle loro finanze. Mio fratello e mia sorella erano andati all’università prima di me, a casa c’erano altri due figli che ancora studiavano. E mio padre non stava più bene. Anche lui si stava spegnendo lentamente su quella sedia a rotelle, con gli occhi lucidi e l’orgoglio di sempre. Riuscii a laurearmi in quattro anni.
Alla cerimonia con me c’era solo il mio compagno di stanza, Antonio Angelico, che oggi fa l’avvocato in provincia di Siracusa. Provai molta gioia, ma quando tornai a casa feci finta di nulla. Anch’io come mio padre ho imparato a centellinare le emozioni.
Ho avuto sempre in mente di fare qualcosa per la mia terra. Ho sempre odiato i prepotenti. Dopo la laurea in Giurisprudenza, mi è subito balenata l’idea di fare il concorso in magistratura, ma me la sono tenuta per me. Ho frequentato per un po’ lo studio che era stato di mio zio. E poi ho cominciato a prepararmi. Due anni, senza tregua, inchiodato a una sedia. Nessuno sapeva che cosa stessi facendo. Mi venivano in mente le parole di mia madre ossessionata dall’idea di non fare brutta figura.
Quante volte le ho sentito dire le stesse parole. Non bisogna fare brutta figura, perché altrimenti la gente parla. E noi non dobbiamo dare nell’occhio. Ho superato lo scritto, arrivando diciassettesimo su dodicimila candidati e poi ho superato l’orale. Anche in quell’occasione, con mio padre ci siamo parlati con gli occhi. Mia madre invece mi ha dato una pacca sulle spalle e mi ha detto: non dimenticare mai chi sei e da dove vieni. Ai miei devo molto, soprattutto ora che non ci sono più. Non finirò mai di ringraziarli.
L’impatto con il mondo della magistratura è stato entusiasmante.
Ho avuto dei colleghi che mi hanno aiutato a capire meglio questo mestiere. Dopo due anni da uditore a Catanzaro, dovetti prendere una decisione importante: la scelta della sede. C’erano posti vacanti a Sanremo, Venezia, Brescia e Torino, ma io scelsi di restare in Calabria, dove sono nato.
Non è stata una scelta sofferta. Non c’è posto migliore di quello in cui sei nato e cresciuto. Ho deciso di restare, pur sapendo di andare incontro a molte privazioni. Ma l’ho fatto con la convinzione di poter contribuire a risolvere i problemi di questa terra. Io sono rimasto accanto alle mie radici per costruire il futuro, il mio e quello della mia famiglia.
Non mi sono mai pentito di quella scelta. Anche se ci sono stati momenti difficili. Ricordo la mia prima indagine. Feci arrestare l’assessore alla Forestazione e, in seguito a quel provvedimento, la giunta regionale fu costretta a dimettersi. Cominciarono così i primi problemi. Minacce al telefono, lettere minatorie. Qualcuno esplose alcuni colpi di pistola contro l’abitazione della mia fidanzata, seguiti da una telefonata: stai per sposare un uomo morto. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza mi assegnò una scorta. Intervenne anche l’Associazione nazionale magistrati e, alla riunione che ne seguì, un collega più anziano cercò di dare un’interpretazione diversa alle minacce, ipotizzando che a sparare fosse stato un rivale in amore. Capii che non sarebbe stato facile fare il magistrato. E che forse mia madre aveva ragione a diffidare anche della propria ombra.
Nel 1993 ci furono altre minacce. Un collaboratore disse che stavano per preparare un attentato contro di me. C’era un’aria molto pesante attorno a me. Avevo fatto diverse indagini sui traffici di droga, nei quali erano coinvolti i clan della Locride, e il tuffo improvviso nell’universo della ’ndrangheta era stato appassionante, intenso e formativo. A Platì, per esempio, avevo scoperto come le principali famiglie di quel paese avessero strappato ai proprietari un’intera montagna che sconfinava nel comune di Varapodio. Molti avvocati mi rimproveravano di assecondare troppo il lavoro delle forze dell’ordine. Prestavo attenzione a ogni minimo segnale.
La mia famiglia ha reagito con preoccupazione, comprendendo che non c’era alternativa. Non avrebbe avuto senso vivere da vigliacchi.
Nel 2005 due ’ndranghetisti sono stati intercettati mentre discutevano nel carcere di Melfi di come far saltare in aria me e la mia scorta. «Perché tutto questo sangue?» chiedeva uno dei due. E l’altro: «Perché Gratteri ci ha rovinato». Qualche giorno dopo nella piana di Gioia Tauro venne scoperto un arsenale: pistole, lanciarazzi, kalashnikov, un chilo di plastico e alcune bombe a mano.
Ho cercato di mantenere i nervi saldi e di continuare nel mio lavoro. Per fortuna non mi annoio mai. Ormai sono abituato. Con la morte bisogna convivere. Quando è morto mio padre non sono potuto andare neanche al funerale. Era un momento particolare, anche allora si parlava di attentati.
Mi sono sempre mosso con estrema cautela, evitando sia le false complicità che gli atteggiamenti autoritari o arroganti. Non ho mai umiliato nessuno, abusando del mio potere. Ma ho sempre preteso che il mio ruolo venisse riconosciuto.
Tra me e loro c’è sempre stato un tavolo di mezzo. Il lavoro del magistrato consiste anche nel padroneggiare una griglia interpretativa dei segni. Per un calabrese come me, rientra nell’ordine delle cose. Nella ’ndrangheta tutto è messaggio, tutto è carico di significati. A volte i silenzi valgono più di mille parole. Non esistono particolari trascurabili.
Quella in trincea è anche una vita di rinuncia. Per i profili di sicurezza, la mia vita privata è fortemente condizionata dal lavoro che faccio. Negli ultimi vent’anni non sono mai entrato in un cinema, né ho potuto seguire una partita di calcio allo stadio o fare una passeggiata sul corso. Ma a due cose non ho mai rinunciato. La prima è coltivare la terra. La seconda è andare nelle scuole per spiegare ai giovani perché non conviene essere ’ndranghetisti. La passione per l’agricoltura l’ho ereditata da mio padre, perché a Gerace, dove vivo con mia moglie e i nostri due figli, abbiamo sempre avuto della terra e l’abbiamo sempre coltivata.
Sono i miei momenti di libertà. Parlare con i giovani è altrettanto gratificante perché è come lavorare la terra, coltivare nella speranza di raccogliere frutti. Un mio caro amico, Antonio Nicaso, quando abbiamo scritto La Malapianta, mi ha chiesto qual è il primo pensiero quando mi sveglio. Ho risposto: «Quello di potermi guardare allo specchio, senza avere nulla da rimproverarmi.
E l’ultimo? «Addormentarmi con la coscienza a posto». Hans Kelsen, un grande giurista, diceva che il singolo non può raggiungere mai la felicità individuale perché l’unica felicità possibile è quella collettiva. La felicità sociale si chiama giustizia, che non è qualcosa di già dato, ma qualcosa che bisogna costruire giorno per giorno. Questa tensione verso la giustizia caratterizza tutta la vicenda umana, senza questa idea di giustizia non può esistere la libertà, non può esistere la felicità, non può esistere il progresso”.
FONTE